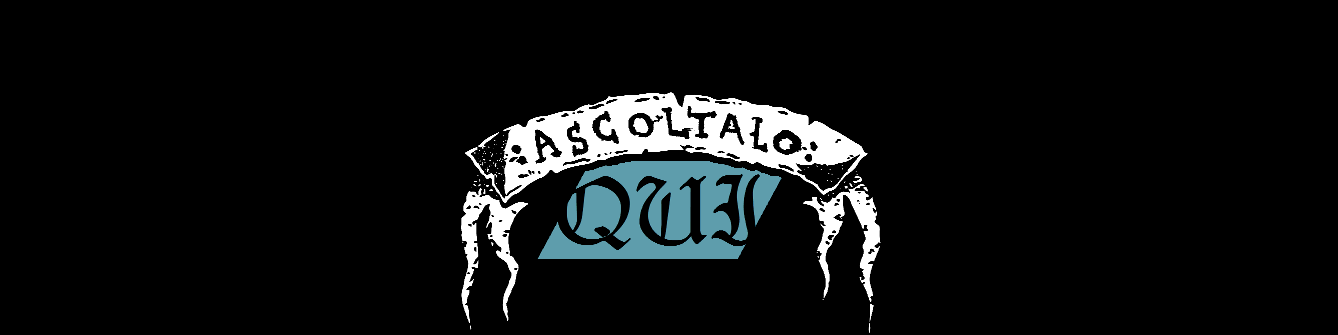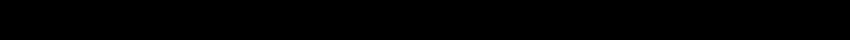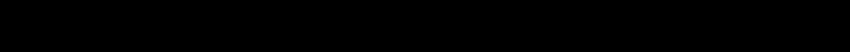E quando tutto sembra essere stato detto e stato fatto, noi si cerca sempre di stupirvi in un modo o nell’altro. Anche perché sarebbe un peccato imperdonabile smarrirsi per strada qualche grande o (a seconda delle preferenze) grandissimo disco uscito lungo lo scorso dicembre, facendolo per il mero fatto che l’annata è ormai conclusa, che guardiamo al nuovo e che le mirabolanti ed immancabili top 20 di fine anno sono già state stilate e pubblicate. No?
Del resto gli esclusi, da quei listoni riepilogativi delle preferenze, lo si sa, sono proverbialmente sempre presenti nella loro assordante assenza – e difatti, oggi, ne troviamo almeno uno lì nascosto (ma nemmeno troppo) tra i quattro più bei dischi della scorsa mensilità che andiamo ad indagare col presente articolo. In aggiunta, l’occasione resta ghiotta per qualche consiglio in volata finale inclusiva anche di un lussuoso EP che tutto sembra essere fuorché un EP; uno di quelli di cui veramente non si può non fare onorata menzione.
L’album che apre le ultimissime danze riservate al 2023 non dovrebbe ad ogni modo esservi totalmente nuovo: ultima vera bomba dell’anno, a mani basse; ultimo disco de La Gente Deve Sapere lungo l’appena terminata stagione, nonché uno dei prediletti da tre redattori qualche settimana fa. Il più che atteso ritorno “Vor Uns Das Feuer, Über Uns Der Himmel” dei tedeschi Wolfhetan è senza girarci attorno un album troppo impegnativo e profondo per essere uno di quelli che si può dire faranno parlare; ma questo dice tristemente molto più sullo stato attuale delle cose in questo mondo che non, di rimando, su di lui. Al contrario -e chi ci segue più spesso lo sa- questo può a ben vedere e sentire dirsi un autentico attestato di merito già di per sé. Chi a suo tempo ha conosciuto “Was Der Tag Nicht Ahnt” non poteva non aspettarlo da un pezzo e presumibilmente l’avrà già ascoltato; chi l’ha già ascoltato l’avrà poi probabilmente già apprezzato… Tutti gli altri aprano occhi, orecchie e cuore…

![]() “[…] Una riflessione dalla classe unica; una solitaria, serale dissertazione con sé stessi, accanto al fuoco o al chiarore soffuso di una calda, ingiallita abat jour in legno scuro e nodoso, odendo nel nulla le risposte di un rapace notturno che alla luce pallida della luna intona con dolcezza una canzone amara, mentre il tempo passa senza aspettare nessuno, mietendo vittime là fuori nel freddo del mondo. […] E nella mente si delinea l’immagine di un tramonto di fuoco ed oro in cui acqua, cielo, fronde e terra dipingono una cosa sola, soggetto e cornice all’unisono, percependo vento e pioggia sul viso, nebbia nelle membra e silenzio nella ragione. In ciò una consapevolezza che sfoltisce le prospettive: tutto quel che ci è dato è la scelta di cosa fare con i tempi ed il preciso tempo che è concesso a nostra disposizione; quello che ci separa e ci unisce, quello che vorremmo rivivere e quello che temiamo come un incubo perché quando non ci saremo più, a nostro dispetto, lui ci sarà ancora. Perché il tempo è il nemico, ma è anche tutto ciò che abbiamo. E forse proprio perciò è nostro nemico più acerrimo.”
“[…] Una riflessione dalla classe unica; una solitaria, serale dissertazione con sé stessi, accanto al fuoco o al chiarore soffuso di una calda, ingiallita abat jour in legno scuro e nodoso, odendo nel nulla le risposte di un rapace notturno che alla luce pallida della luna intona con dolcezza una canzone amara, mentre il tempo passa senza aspettare nessuno, mietendo vittime là fuori nel freddo del mondo. […] E nella mente si delinea l’immagine di un tramonto di fuoco ed oro in cui acqua, cielo, fronde e terra dipingono una cosa sola, soggetto e cornice all’unisono, percependo vento e pioggia sul viso, nebbia nelle membra e silenzio nella ragione. In ciò una consapevolezza che sfoltisce le prospettive: tutto quel che ci è dato è la scelta di cosa fare con i tempi ed il preciso tempo che è concesso a nostra disposizione; quello che ci separa e ci unisce, quello che vorremmo rivivere e quello che temiamo come un incubo perché quando non ci saremo più, a nostro dispetto, lui ci sarà ancora. Perché il tempo è il nemico, ma è anche tutto ciò che abbiamo. E forse proprio perciò è nostro nemico più acerrimo.”
[Leggi di più nella recensione che lo elegge disco della settimana, qui.]
![]() “Un mondo così caratteristico, sospeso fra dicotomie assolute e dotato di un quid tanto brillante quanto difficile da afferrare come quello dei Wolfhetan può offrire un suo nuovo scorcio dopo così tanto pur senza sembrare anacronistico o stantio: il susseguirsi torrenziale di “Vor Uns Das Feuer, Über Uns Der Himmel” è tremendamente intenso ed inizialmente tortuoso da seguire sugli aspri tornanti infuocati dei suoi otto brani; non per la loro lunghezza, ma per un linguaggio fatto di sprazzi elementali grezzi, mai magniloquenti o eccessivamente stratificati, portati avanti con un corredo strumentale ridotto all’essenziale e forse per questo ancora più netti e travolgenti. Il terzo full-length del progetto tedesco, che a giudicare da tempi e sensazioni potrebbe segnare la conclusione stessa del percorso artistico, è essenza pura dello spirito oscuro, pagano ed elegante che fin dai primordi lo contraddistingue; lascito ermetico di un’arte che richiede dedizione e devozione, impalpabile come le increspature del vento sul pelo dell’acqua, tempestosa ma fugace come il bagliore di un fulmine, eppure eternamente in attesa che qualche viandante ne colga l’immenso valore e lo custodisca come un prezioso tesoro.”
“Un mondo così caratteristico, sospeso fra dicotomie assolute e dotato di un quid tanto brillante quanto difficile da afferrare come quello dei Wolfhetan può offrire un suo nuovo scorcio dopo così tanto pur senza sembrare anacronistico o stantio: il susseguirsi torrenziale di “Vor Uns Das Feuer, Über Uns Der Himmel” è tremendamente intenso ed inizialmente tortuoso da seguire sugli aspri tornanti infuocati dei suoi otto brani; non per la loro lunghezza, ma per un linguaggio fatto di sprazzi elementali grezzi, mai magniloquenti o eccessivamente stratificati, portati avanti con un corredo strumentale ridotto all’essenziale e forse per questo ancora più netti e travolgenti. Il terzo full-length del progetto tedesco, che a giudicare da tempi e sensazioni potrebbe segnare la conclusione stessa del percorso artistico, è essenza pura dello spirito oscuro, pagano ed elegante che fin dai primordi lo contraddistingue; lascito ermetico di un’arte che richiede dedizione e devozione, impalpabile come le increspature del vento sul pelo dell’acqua, tempestosa ma fugace come il bagliore di un fulmine, eppure eternamente in attesa che qualche viandante ne colga l’immenso valore e lo custodisca come un prezioso tesoro.”
![]() “Dopo una lunghissima attesa ritornano i tedeschi Wolfhetan con il nuovo “Vor Uns Das Feuer, Über Uns Der Himmel”, disco che nonostante gli anni di distanza resta musicalmente fedele al precedente “Was Der Tag Nicht Ahnt” trattandosi infatti di canzoni bene o male composte e registrate subito dopo l’uscita dell’album appena citato. L’atmosfera che si delinea nel corso di queste otto tracce è nuovamente unica nel suo genere ed esalta appieno la meravigliosa estetica che caratterizza tutta l’ambientazione targata Wolfhetan, anche se il risultato finale, seppure ottimo e qualitativamente perfino superiore al secondo album, appare forse a tratti meno coeso rispetto al suo predecessore e con scelte di produzione a volte confusionarie e discutibili. A mantenere il tutto ad alti livelli ci pensano tuttavia una capacità compositiva ed un’espressività fuori dal tempo che riescono a rendere godibile anche un prodotto rimasto, per una ragione o per l’altra, fermo per gli estimatori ai blocchi di partenza da tanto, troppo tempo.”
“Dopo una lunghissima attesa ritornano i tedeschi Wolfhetan con il nuovo “Vor Uns Das Feuer, Über Uns Der Himmel”, disco che nonostante gli anni di distanza resta musicalmente fedele al precedente “Was Der Tag Nicht Ahnt” trattandosi infatti di canzoni bene o male composte e registrate subito dopo l’uscita dell’album appena citato. L’atmosfera che si delinea nel corso di queste otto tracce è nuovamente unica nel suo genere ed esalta appieno la meravigliosa estetica che caratterizza tutta l’ambientazione targata Wolfhetan, anche se il risultato finale, seppure ottimo e qualitativamente perfino superiore al secondo album, appare forse a tratti meno coeso rispetto al suo predecessore e con scelte di produzione a volte confusionarie e discutibili. A mantenere il tutto ad alti livelli ci pensano tuttavia una capacità compositiva ed un’espressività fuori dal tempo che riescono a rendere godibile anche un prodotto rimasto, per una ragione o per l’altra, fermo per gli estimatori ai blocchi di partenza da tanto, troppo tempo.”


 Gli undici anni abbondanti che separano il disco dei Wolfhetan dal suo fratello maggiore sono battuti dai tredici che staccano “Trolldom”, ritorno in pista dei noveregesi Troll, dal suo precedente in studio “Neo-Satanic Supremacy”. Non un come-back di ritono alle radici come si vociferava o si voleva far credere (anche e soprattutto con l’EP rompighiaccio del 2020), tuttavia nel suo quinto full-length il gruppo di Nagash ha di nuovo, ancora una volta e assolutamente, i suoi numeri.
Gli undici anni abbondanti che separano il disco dei Wolfhetan dal suo fratello maggiore sono battuti dai tredici che staccano “Trolldom”, ritorno in pista dei noveregesi Troll, dal suo precedente in studio “Neo-Satanic Supremacy”. Non un come-back di ritono alle radici come si vociferava o si voleva far credere (anche e soprattutto con l’EP rompighiaccio del 2020), tuttavia nel suo quinto full-length il gruppo di Nagash ha di nuovo, ancora una volta e assolutamente, i suoi numeri.
![]() “Non fosse per una produzione clamorosamente toppata nel suo miscuglio inaspettatamente piatto di frequenze medie a dispetto di una encomiabile apertura generale, una spiacevole via di mezzo che non favorisce né la spinta delle tastiere quali elemento fondativo della composizione, né il blocco chitarristico reso così incapace di graffiare come dovrebbe (almeno, tale senza una manuale sistemazione dell’equalizzazione complessiva lungo l’ascolto), “Trolldom” potrebbe tranquillamente essere il miglior disco dei Troll: impregnato di sinfonico feeling stregato non così dissimile dal suo predecessore ma con un’atmosfera antica ancor più memore del leggendario “Drep De Kristne” (“The Soil Turns Red”), al contempo non dimentico di tutta l’evoluzione Industrial e sperimentale attuata dal mastermind Stian Arnesen tra il funambolismo “Nexus Polaris”, il cyber-mood “The Last Predators” e “Universal”, e la meccanicità “SETI”, così com’è graziato da una fortunata scrittura appuntita che regala ottime canzoni a dispetto della resa sonora offrendo una prestazione matura, variegata in intenti (si confrontino l’ineccepibile groove generale, eccellente com’è in “Angerboda (Sorgvarsleren)”, con l’efferata bomba “He Who Dwells”) coerente col suo passato. Forse un po’ safe, ma mai eccessivamente prevedibile.”
“Non fosse per una produzione clamorosamente toppata nel suo miscuglio inaspettatamente piatto di frequenze medie a dispetto di una encomiabile apertura generale, una spiacevole via di mezzo che non favorisce né la spinta delle tastiere quali elemento fondativo della composizione, né il blocco chitarristico reso così incapace di graffiare come dovrebbe (almeno, tale senza una manuale sistemazione dell’equalizzazione complessiva lungo l’ascolto), “Trolldom” potrebbe tranquillamente essere il miglior disco dei Troll: impregnato di sinfonico feeling stregato non così dissimile dal suo predecessore ma con un’atmosfera antica ancor più memore del leggendario “Drep De Kristne” (“The Soil Turns Red”), al contempo non dimentico di tutta l’evoluzione Industrial e sperimentale attuata dal mastermind Stian Arnesen tra il funambolismo “Nexus Polaris”, il cyber-mood “The Last Predators” e “Universal”, e la meccanicità “SETI”, così com’è graziato da una fortunata scrittura appuntita che regala ottime canzoni a dispetto della resa sonora offrendo una prestazione matura, variegata in intenti (si confrontino l’ineccepibile groove generale, eccellente com’è in “Angerboda (Sorgvarsleren)”, con l’efferata bomba “He Who Dwells”) coerente col suo passato. Forse un po’ safe, ma mai eccessivamente prevedibile.”
![]() “Il sound design tondeggiante di un comparto chitarristico dagli artigli spuntati rimane a conti fatti l’unica recriminazione possibile verso un come-back il quale, piuttosto che riallacciarsi ciecamente agli anni Novanta come fatto da parecchi colleghi rientrati di recente in partita, sceglie invece e ben più dignitosamente di lavorare sull’intero corpus dell’entità norvegese. Non vengono dunque tralasciati i sentori industriali affacciatisi dopo lo storico “Drep De Kristne”, e l’incontro tra il gusto cyber/sci-fi delle tastiere e la carica rockeggiante delle ritmiche fa difatti ricordare con piacere il mai dimenticato “Blodsvept” dei figliocci Finntroll. Proprio come quel piccolo gioiello ormai ultradecennale, “Trolldom” non si pone affatto come obbiettivo l’essere inattaccabile sul piano formale quanto più il lasciare una sua impronta, seguendo in ciò la linea di pensiero di un fine artigiano quale è sempre stato il buon Nagash; forse imperfetto ma pure imprevedibile, e di questi tempi di continua standardizzazione si tratta davvero di un complimento non da poco.”
“Il sound design tondeggiante di un comparto chitarristico dagli artigli spuntati rimane a conti fatti l’unica recriminazione possibile verso un come-back il quale, piuttosto che riallacciarsi ciecamente agli anni Novanta come fatto da parecchi colleghi rientrati di recente in partita, sceglie invece e ben più dignitosamente di lavorare sull’intero corpus dell’entità norvegese. Non vengono dunque tralasciati i sentori industriali affacciatisi dopo lo storico “Drep De Kristne”, e l’incontro tra il gusto cyber/sci-fi delle tastiere e la carica rockeggiante delle ritmiche fa difatti ricordare con piacere il mai dimenticato “Blodsvept” dei figliocci Finntroll. Proprio come quel piccolo gioiello ormai ultradecennale, “Trolldom” non si pone affatto come obbiettivo l’essere inattaccabile sul piano formale quanto più il lasciare una sua impronta, seguendo in ciò la linea di pensiero di un fine artigiano quale è sempre stato il buon Nagash; forse imperfetto ma pure imprevedibile, e di questi tempi di continua standardizzazione si tratta davvero di un complimento non da poco.”
 Si passa di veterani in giovani leve approdando sulle sponde svedesi degli Hinsides, già apprezzati con “Under Betlehems Brinnande Stjärna” nel 2021, e di riconferma come ormai cavalli di punta del roster Shadow Records se si considera l’ottimo pedrigree Ultra Silvam di M.A.. Amanti delle proposte più selvagge e Raw dove non è occultata alcuna abilità altresì in gran spolvero, sia per scrittura che per inventiva: attenzione qui! Ordog lo elegge suo personale disco del mese e Kirves ci va dietro come segue.
Si passa di veterani in giovani leve approdando sulle sponde svedesi degli Hinsides, già apprezzati con “Under Betlehems Brinnande Stjärna” nel 2021, e di riconferma come ormai cavalli di punta del roster Shadow Records se si considera l’ottimo pedrigree Ultra Silvam di M.A.. Amanti delle proposte più selvagge e Raw dove non è occultata alcuna abilità altresì in gran spolvero, sia per scrittura che per inventiva: attenzione qui! Ordog lo elegge suo personale disco del mese e Kirves ci va dietro come segue.
![]() “S’è vero che i progetti solisti rivestono il ruolo tutt’altro che secondario di illimitata sandbox creativa, allora il secondogenito di questa mefitica creatura svedese “Hinsides Hörs Djävulsklockans Urklang” è proprio il passo in avanti che era lecito attendersi dopo il focoso debutto di due inverni fa. La mostruosità di nome Hinsides si sta piano piano evolvendo in qualcosa di diverso dalla ipotetica dispensa di materiale scartato dagli Ultra Silvam, innestando con sempre maggior perizia compositiva le suggestioni Hard ‘N’ Heavy, Gothic Rock e persino Horror Punk lasciate intendere dall’esordio. L’odore pestilenziale di cento bare scoperchiate trova pertanto naturale corrispondenza nelle campane dagli inquietanti rintocchi funebri, nei riff danzighiani che furoreggiano una volta calati i bpm, ed in una chitarra solista sorprendentemente elevata ad MVP di buona parte del lavoro – tra stacchi improvvisi e assoli da guitar hero votati all’Avversario. Il consiglio è allora di accalappiarsi una copia fisica per godersi pure la cover dei Plasmatics, e così facendo sostenere ulteriormente questa nuova ondata di giovani svedesi macellai delle sette note.”
“S’è vero che i progetti solisti rivestono il ruolo tutt’altro che secondario di illimitata sandbox creativa, allora il secondogenito di questa mefitica creatura svedese “Hinsides Hörs Djävulsklockans Urklang” è proprio il passo in avanti che era lecito attendersi dopo il focoso debutto di due inverni fa. La mostruosità di nome Hinsides si sta piano piano evolvendo in qualcosa di diverso dalla ipotetica dispensa di materiale scartato dagli Ultra Silvam, innestando con sempre maggior perizia compositiva le suggestioni Hard ‘N’ Heavy, Gothic Rock e persino Horror Punk lasciate intendere dall’esordio. L’odore pestilenziale di cento bare scoperchiate trova pertanto naturale corrispondenza nelle campane dagli inquietanti rintocchi funebri, nei riff danzighiani che furoreggiano una volta calati i bpm, ed in una chitarra solista sorprendentemente elevata ad MVP di buona parte del lavoro – tra stacchi improvvisi e assoli da guitar hero votati all’Avversario. Il consiglio è allora di accalappiarsi una copia fisica per godersi pure la cover dei Plasmatics, e così facendo sostenere ulteriormente questa nuova ondata di giovani svedesi macellai delle sette note.”
![]() “Un basso onnipresente che martella fangoso come la pala di un becchino indefesso a ribaltar terra al chiaro di luna, lead sinistre che serpeggiano qua e là ovattate e fantasmagoriche tra svirgolate Heavy e pinnate infervorate, vocals gorgoglianti e cruente dal tono spietatamente credibile: se per uno stile più lo-fi ma meno iperfrenetico dei cugini Ultra Silvam ventisette minuti (esclusivi di bonus) rischiano di aggiungere un po’ troppa poca carne al fuoco, il secondo disco degli Hinsides riesce comunque molto bene nella costruzione di uno scenario che fra cliché volutamente e sfrontatamente esasperati e qualche tocco di truculenta classe si fa orrorifico e peculiare. All’apparenza sporco e melmoso ma accuratamente impreziosito da una tendenza sotterranea al dinamismo e alla melodia, “Hinsides Hörs Djävulsklockans Urklang” risuona fatale e grave come il rintocco delle campane che si ripresentano lungo la tracklist, annunciando che un altro bastimento putrido carico di cadaveri mutilati e sangue incrostato è partito dagli avamposti Shadow Records.”
“Un basso onnipresente che martella fangoso come la pala di un becchino indefesso a ribaltar terra al chiaro di luna, lead sinistre che serpeggiano qua e là ovattate e fantasmagoriche tra svirgolate Heavy e pinnate infervorate, vocals gorgoglianti e cruente dal tono spietatamente credibile: se per uno stile più lo-fi ma meno iperfrenetico dei cugini Ultra Silvam ventisette minuti (esclusivi di bonus) rischiano di aggiungere un po’ troppa poca carne al fuoco, il secondo disco degli Hinsides riesce comunque molto bene nella costruzione di uno scenario che fra cliché volutamente e sfrontatamente esasperati e qualche tocco di truculenta classe si fa orrorifico e peculiare. All’apparenza sporco e melmoso ma accuratamente impreziosito da una tendenza sotterranea al dinamismo e alla melodia, “Hinsides Hörs Djävulsklockans Urklang” risuona fatale e grave come il rintocco delle campane che si ripresentano lungo la tracklist, annunciando che un altro bastimento putrido carico di cadaveri mutilati e sangue incrostato è partito dagli avamposti Shadow Records.”
 Ancora una volta il buon Ordog ci delizia con un consiglio solitario in dirittura d’arrivo: tocca ad altri reduci di mille battaglie quali i Varathron farsi sentire, forti a quanto sembra di una seconda giovinezza iniziata nel “Patriarchs Of Evil” del 2018 e che prosegue indefessa qui, oggi, nel nuovo “The Crimson Temple” fuori sempre per la polacca Agonia Records (che attendiamo di qui a pochi giorni al varco Inquisition)…
Ancora una volta il buon Ordog ci delizia con un consiglio solitario in dirittura d’arrivo: tocca ad altri reduci di mille battaglie quali i Varathron farsi sentire, forti a quanto sembra di una seconda giovinezza iniziata nel “Patriarchs Of Evil” del 2018 e che prosegue indefessa qui, oggi, nel nuovo “The Crimson Temple” fuori sempre per la polacca Agonia Records (che attendiamo di qui a pochi giorni al varco Inquisition)…
![]() “Inscalfibili ed incorruttibili custodi di un culto i cui adepti vanno di continuo assottigliandosi, i Varathron restano ad oggi tra i pochissimi sopravvissuti della gloriosa scena greca dotati di quel senso della misura necessario a rendere credibile questo stile ormai trent’anni dopo la sua nascita. Il magico sense-of-wonder mediterraneo, raggiunto come da tradizione a colpi di tastiere soffuse e galvanizzanti break sui tempi medi, non imbriglia mai la carica di pezzi spesso e volentieri lanciati a velocità sostenute e benedetti da un suono megalitico, studiato appositamente per saltare con naturalezza tra Black, Thrash ed Heavy Metal senza dare l’idea di un mix tenuto insieme per miracolo. Alla stregua dei grandi classici dell’antica Grecia, “The Crimson Temple” pare in linea col sentire odierno anche quando aderisce del tutto ai canoni di metà anni Novanta, in quanto essi come ogni esito artistico d’alto livello sono privi di data di scadenza: imperdibile quindi per i patiti di stregonerie elleniche, così come per i profani rimasti finora all’oscuro di una band dal contributo fondamentale alla causa estrema.”
“Inscalfibili ed incorruttibili custodi di un culto i cui adepti vanno di continuo assottigliandosi, i Varathron restano ad oggi tra i pochissimi sopravvissuti della gloriosa scena greca dotati di quel senso della misura necessario a rendere credibile questo stile ormai trent’anni dopo la sua nascita. Il magico sense-of-wonder mediterraneo, raggiunto come da tradizione a colpi di tastiere soffuse e galvanizzanti break sui tempi medi, non imbriglia mai la carica di pezzi spesso e volentieri lanciati a velocità sostenute e benedetti da un suono megalitico, studiato appositamente per saltare con naturalezza tra Black, Thrash ed Heavy Metal senza dare l’idea di un mix tenuto insieme per miracolo. Alla stregua dei grandi classici dell’antica Grecia, “The Crimson Temple” pare in linea col sentire odierno anche quando aderisce del tutto ai canoni di metà anni Novanta, in quanto essi come ogni esito artistico d’alto livello sono privi di data di scadenza: imperdibile quindi per i patiti di stregonerie elleniche, così come per i profani rimasti finora all’oscuro di una band dal contributo fondamentale alla causa estrema.”
Valeva dunque la pena di recuperare insieme anche gli ultimissimi dischi regalatici dal 2023? Se la vostra risposta è affermativa, come speriamo sia una volta arrivati fin qui, allora non resta che da gioire per un altro trionfale lavoro diciamo bonus, il quale per sole (benché inappuntabili) ragioni concettuali dei suoi autori non è stato rilasciato come un effettivo full-length. Chi, in tempi recenti, si è già inserito con prepotenza in questo nobile filone di rari mini-allbum che non tanto o non soltanto per merito qualitativo non sono affatto reputabili minori (e.g. i forse brevi ma sicuramente iconici “Morbid Tales”, “Hordanes Land”, “First Spell”, “From Haavardstun”, “Satanic Art”, “Apokalypse”, “Under The Moonspell” tra gli infiniti altri – o gli imperdibili esperimenti di “Faustian Echoes”, “Spectres Over Transylvania”, “Urminnes Hävd”), bensì che non lo sono per questo motivo aggiunto al quantitativo ben poco mini di musica proposta (si pensi a dei densissimi e più rari “Kénôse”, “Tulimyrsky” o “Nightshade Forests”), torna sul luogo del misfatto per ammaliarci con nuove storie dal passato in attesa di ciò che verrà.
 Se infatti gli autori sono gli Árstíðir Lífsins -la band che potrebbe raddrizzare, servisse, un’annata da sola- e se si conosce un filo la loro storia discografica, la cosa non sorprende più di tanto: un po’ come avvenne per “Heljarkviða” nel 2016, “Hermalausaz” (che potete ascoltare nella sua interezza qui) ci ripropone il gruppo al suo meglio come sugosa intercapedine tra quel che sarà e la doppia “Saga Á Tveim Tungum” di album usciti tra il 2019 ed il 2020, anticipando coi suoi tre quarti d’ora suddivisi in due pezzi da oltre venti minuti l’uno il prossimo full-length del trio (già pronto e sottoposto agli ultimi passaggi di consegna prima di finire sugli scaffali – per il momento rimandato rispetto alle intenzioni iniziali ma ipoteticamente in arrivo verso la seconda metà del 2024). Con dentro il materiale che farebbe insomma la fortuna di intere altre discografie, e senza inutili descrizioni: aspettatevi tutto quel che dovete aspettarvi. E di più.
Se infatti gli autori sono gli Árstíðir Lífsins -la band che potrebbe raddrizzare, servisse, un’annata da sola- e se si conosce un filo la loro storia discografica, la cosa non sorprende più di tanto: un po’ come avvenne per “Heljarkviða” nel 2016, “Hermalausaz” (che potete ascoltare nella sua interezza qui) ci ripropone il gruppo al suo meglio come sugosa intercapedine tra quel che sarà e la doppia “Saga Á Tveim Tungum” di album usciti tra il 2019 ed il 2020, anticipando coi suoi tre quarti d’ora suddivisi in due pezzi da oltre venti minuti l’uno il prossimo full-length del trio (già pronto e sottoposto agli ultimi passaggi di consegna prima di finire sugli scaffali – per il momento rimandato rispetto alle intenzioni iniziali ma ipoteticamente in arrivo verso la seconda metà del 2024). Con dentro il materiale che farebbe insomma la fortuna di intere altre discografie, e senza inutili descrizioni: aspettatevi tutto quel che dovete aspettarvi. E di più.
Resta giusto spazio per un’altra manciata di consigli per i più affamati, ma questa volta di nuovo su formato esteso. Parliamo di tutti quelli che non ce l’hanno fatta a finire tra i quattro favoriti nonostante le pessime intenzioni e la qualità non esattamente trascurabile: innanzitutto di “Jadjow” dei britannici Void, per la rubrica m’è finito del talento nel mixer – non l’assoluto meglio tra i più coraggiosi dello scorso anno, e sicuramente irriconoscibili dai tempi dell’indimenticato debutto, ma meglio del comunque non brutto “The Hollow Man” e un disco nondimeno consigliato ai lettori dai gusti più sperimentali, strambi e inclini (proprio) alla formula dell’incidentalmente citato “Satanic Art” aggiornata ai tempi attuali; ricordiamo poi “The Nighthold” dei finlandesi Vargrav (che con una simile line-up di campioni poteva sicuramente dare qualcosina di più), non dovessero bastarvi i Troll o quel gusto sinfonico lo voleste un più Danny Elfman; ultimo del trio, ma non necessariamente per gradimento, menzioniamo l’ennesimo progetto in cui Vindsval collabora con altri ragguardevoli artisti, ovverosia l’omonimo debutto degli estemporanei Eitrin dove la mente dei Blut Aus Nord dialoga con gli incubi di Dehn Sohra (Treha Sektori) e Marion Leclercq (Mütterlein) – probabilmente non arte esattamente indimenticabile, ma decisamente meglio di tutti gli ultimi coinvolgimenti dell’illustre compositore francese.
Chiudiamo quindi l’articolo con due grandissime promesse che sono state mantenute probabilmente solo a metà, come ossimorico auspicio di quelle del gennaio in corso d’opera che, al contrario, distruggeranno impianti stereo nonché apparati uditivi su ogni fronte.
– Matteo “Theo” Damiani –